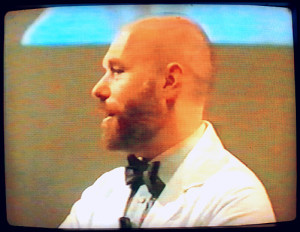Non ho mai fatto quei thread chilometrici e preventivati che alcuni fanno su Twitter. Stasera mi sono accorto che ne stavo facendo uno, e così, per quel che vale, me lo ricopio qui per pensarci su.
Del tutto banale pensare che persino in queste pagine mie in qualche dozzina di mesi ho aggiunto ben poco di concluso (contr: sconclusionato).
Ho riaperto dopo chissà quanto il mio “Analisi chimica per l’arte e il restauro”, che ho scritto nel ’96. Ne ho letto una mezza pagina iniziale insieme ai ragazzi cui inizio a spiegare l’analisi, non per esibire qualcosa (cosa?) ma per vedere il confronto tra il linguaggio
che a me sembrava abbastanza semplice per un pubblico di adulti un quarto di secolo fa, e le loro capacità di comprensione verbale, prima di entrare in quelle concettuali. Un esercizio che faccio spesso con cose scritte da me per rendermi conto del livello di separazione
tra due modi di esprimersi. Quello che a me sembra, o sembrava anni fa, sufficientemente semplice e possibilmente stimolante, non disadorno, per persone con una accettabile cultura di base ma in campi diversi dal mio, e quello con cui mi devo confrontare con il gruppo
di persone cui devo rivolgermi hic et nunc, e che spesso sono diverse non anno per anno ma anche in due classi parallele. Il che è quasi indispensabile per spiegare in modo efficace. Non faccio la semplice retorica dell'”ogni anno sono peggio”, perchè non è vero,
se il livello medio generale ormai è inconcepibilmente basso rispetto a quel che la scuola pubblica dovrebbe garantire e pretendere, questa media è fatta da valori statisticamente dispersi ma che comprendono anche soggetti più che in grado di stare al gioco che la scuola
dovrebbe proporre e giocare insieme a loro. La riflessione più seria è personale, sulla mia lingua, sulla mia capacità di insegnante (comunicatore? divulgatore?) e su come si è evoluta o involuta da quando scrivevo libri. Nei 23 anni da quando ho chiuso l’ultimo ho scritto
in rete, su giornali o chissà dove abbastanza parole per riempire due dozzine di libri, ma sento troppo la difficoltà di scrivere in modo ordinato e concluso, non frammentario, di mettere una parola fine dove so che in realtà non finisce niente, e qualcosa domattina
sarà già superato (visto che perlopiù scrivo di cose tecnico-scientifiche).
Ho nella testa, e già aperti sui pc, almeno tre libri, da anni. Nella testa sono quasi completi, si tratta solo di trovare l’introvabile voglia di dire “si comincia” e di puntare un obiettivo
da raggiungere per dire “basta, finito”. Una volta mi ponevo un limite di tempo, diciamo un paio di mesi, e ce la facevo anche lavorando tutto il giorno in azienda. Ma scrivevo per lettori che in parte conoscevo e di cui sapevo le capacità di comprensione, appunto. È stare
nella scuola, che da un lato mi riempe troppo di dubbi, dall’altro mi fa pensare che passeranno settimane o mesi tra quando ho pensato delle parole e quando verranno lette da qualcuno, che non è più chi ho in mente hic et nunc. Però mi rendo conto che ormai non è più
il tempo di aspettare, perchè passa il mio tempo individuale, ma passa anche il tempo del mondo intorno, e se in questi anni frenetici e convulsi, aperti a un futuro forse migliore, ci dovessero essere quei famosi 25, ho (- il dovere? il bisogno? -) di scrivere.
Se solo trovassi l’ordine mentale, la disciplina per rimettermi a farlo, e avere alla fine quel piacere di chiuderlo. Per poi metterlo magari in rete gratuitamente, come avevo fatto con quello del ’98, tanto i diritti ti pagano poco più che il fastidio di confrontarti
con burocrazie e procedure dell’editore.
Se avessi il coraggio di dire che oso chiudere in una struttura di 150-200 pagine le idee che mi girano nella testa espandendosi come vortici frattali, perchè quel che ne posso dire sensatamente è in fondo così scarso e limitato.
10/9/2021, tarda serata

































 La galleria di fotografie, che
La galleria di fotografie, che  e in fondo
e in fondo  Il dott. Rossi, storico dirigente della struttura, un giorno mi manda a chiamare e mi chiede se, essendo un insegnante ed un divulgatore, fossi in grado di allestire uno spettacolo di tema chimico. O, insomma, qualcosa di meno ovvio della solita conferenza, per una attività di orientamento verso i ragazzi delle scuole medie, che mostravano sempre meno attenzione per gli Istituti Tecnici o per i Licei Scientifici Tecnologici (bella cosa anche quelli, pace all’anima loro, ma continuiamo a non divagare).
Il dott. Rossi, storico dirigente della struttura, un giorno mi manda a chiamare e mi chiede se, essendo un insegnante ed un divulgatore, fossi in grado di allestire uno spettacolo di tema chimico. O, insomma, qualcosa di meno ovvio della solita conferenza, per una attività di orientamento verso i ragazzi delle scuole medie, che mostravano sempre meno attenzione per gli Istituti Tecnici o per i Licei Scientifici Tecnologici (bella cosa anche quelli, pace all’anima loro, ma continuiamo a non divagare).